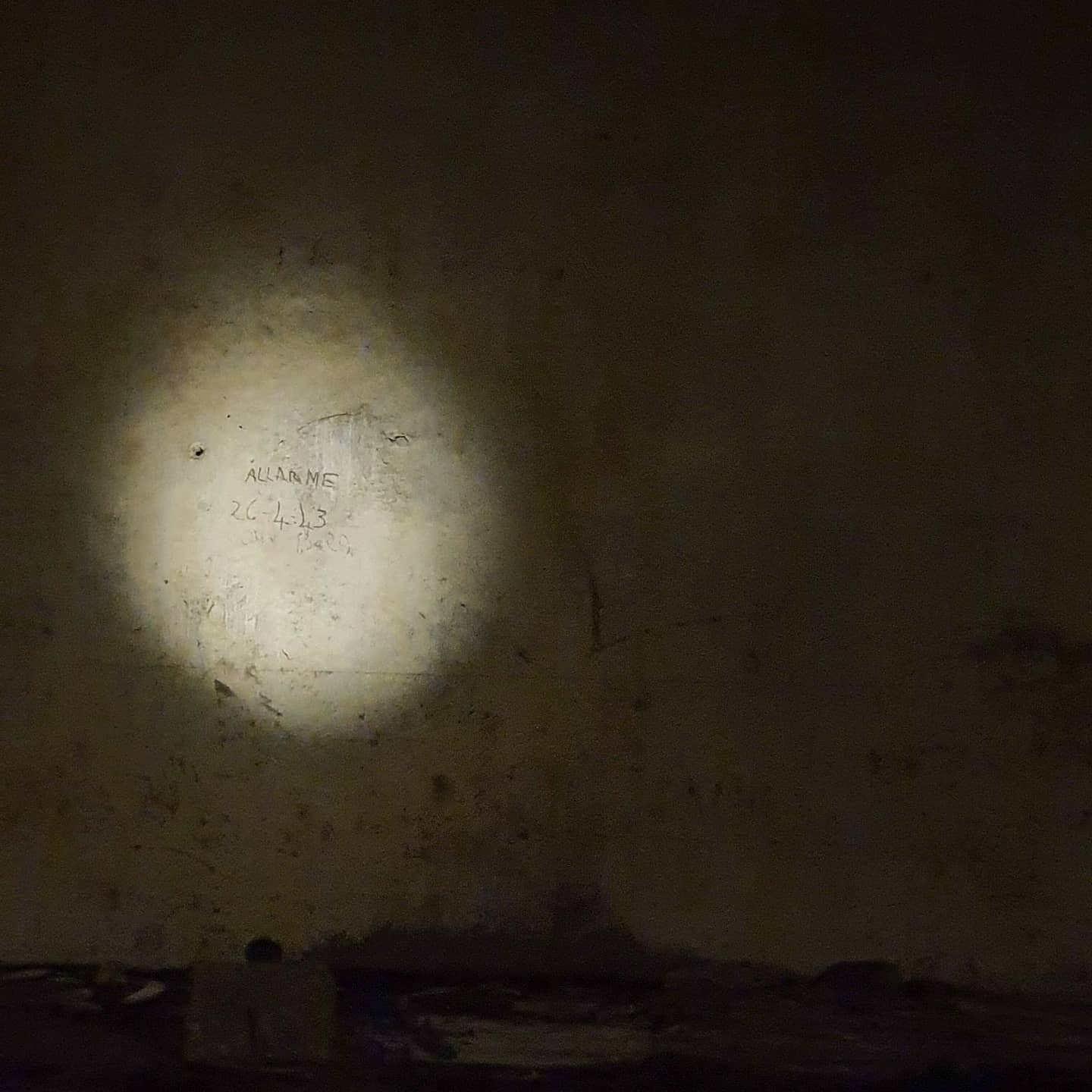I loro sorrisi sono sulfurei
sotto i capelli grigi e cinerei.
Le riconosci le persone
di via Cirillo, Carbonara, Rosaroll, che
hanno l’atteggiamento di quelli a cui
non trema la terra sotto i piedi
ma i giorni sì e
ogni giorno trema
Con i problemi, la rabbia,
I soldi che mancano,
le bollette che aumentano.
Queste persone hanno denti sporchi di caffè, fanno sbattere il cucchiaino
sulla ceramica e quando lo rialzano
non fanno a meno di macchiare la tovaglia.
Il cucchiaino
non lo usano per mescolare lo zucchero,
il caffè lo bevono amaro:
il cucchiaino
lo girano in senso antiorario
solo per rimescolare i minuti,
recuperare manciate di secondi,
Il Tempo giusto per capire
che spesa andare a fare
per un figlio che non può lavorare.
Le loro scosse poco hanno a che fare
con la Terra
perché le faglie che muovono la loro Vita
sono più profonde e
gli effetti
non sono mai superficiali.
Sono persone che chiamo
Telluriche e io sono come loro:
abituate all’inferno,
Pronte alla frana
e nonostante tutto tremi,
fuori e dentro,
Perserverano
Rifiutandosi di sfaldarsi
A ogni profonda vibrazione.




È severamente vietata la riproduzione in tutto in parte dei testi e degli scatti non autorizzata dall’autrice.